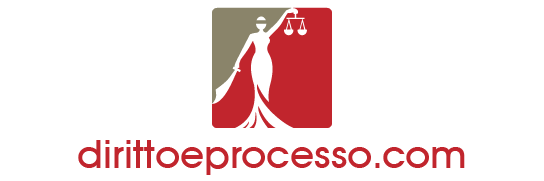Libertà, sicurezza ed immigrazione: il caso Khlaifia ed altri c. Italia.
Con il ricorso n. 16483/12 tre cittadini di nazionalità tunisina adiscono la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ex art. 34 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, contestando alla Repubblica Italiana la violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione per il trattenimento irregolare cui sarebbero stati sottoposti in Italia (isola di Lampedusa e Palermo), nonché la violazione dell’art. 4 del protocollo 4 della Convenzione e del suo art. 13, in combinato disposto con gli artt. 3 e 5.
Le posizioni delle parti, in una vicenda di estrema attualità, vedono contrapposte due esigenze in realtà complementari, che dovrebbero convergere fra loro in un’ottica non solo di efficiente ed efficace amministrazione della res publica, ma anche di solidarietà ed assistenza nella gestione di situazioni delicate come quelle in oggetto.
Da un lato sorge inevitabile la necessità statale italiana di organizzare un flusso migratorio senza precedenti, costante, di proporzioni sempre più drammatiche, che costituisce una vera e propria emergenza umanitaria da coordinare sotto i profili logistici, igienico-sanitari, di sicurezza[1]. Va considerata inoltre la questione della barriera linguistica, che sorge inevitabilmente in relazione alla molteplicità di provenienza dei migranti ed al loro numero, rispetto alle limitate possibilità dei centri di accoglienza di poter in concreto fornire un supporto lessicale continuo ed individuale. Dall’altro lato emergono le istanze dei singoli migranti, soli in terra straniera, in fuga da guerre e carestie, spostati da un luogo all’altro, in attesa di essere rimpatriati; persone che in una condizione di profonda difficoltà rivendicano una libertà di movimento senza illegittimi confinamenti di sorta, siano essi costituiti da una centro di accoglienza, un parco o una nave adibita temporaneamente a spazio di smistamento e/o permanenza.
La sentenza del 1 settembre 2015 – nel riconoscere fondate le istanze dei tre tunisini, con conseguente condanna dello stato italiano nei termini che si diranno – effettua una elaborata ricognizione che tocca ed analizza alcuni fra i principi fondanti gli ordinamenti giuridici contemporanei, sia di natura nazionale che sovranazionale, tracciando un excursus ermeneutico molto articolato.
Una prima quaestio su cui verte la pronuncia riguarda anzitutto la possibilità di qualificare come degradante il trattamento subito dai ricorrenti durante la loro permanenza in territorio italiano, ovvero se le condizioni in cui sono stati trattenuti possano considerarsi lesive della dignità umana, e pertanto contrarie all’articolo 3 della Convenzione.
Nella sua ricostruzione la Corte sottolinea con decisione la natura dell’articolo 3 CEDU, in base al quale «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»
La disposizione de qua si configura quale “clausola essenziale” della Convenzione, inderogabile, costituente uno dei “valori fondamentali delle società democratiche” e, in quanto tale, avente rilevanza non solo all’interno della Convenzione ma soprattutto quale principio generale di ogni ordinamento nazionale: la libertà dell’individuo dunque, in generale come nelle fattispecie concrete, non può essere disattesa, a fronte della sua natura di principio inderogabile e fondamento della società civile contemporanea.
Nel caso in analisi i ricorrenti lamentavano una lesione della loro libertà individuale, connessa ad un trattenimento degradante ed inumano, legato alle condizioni in cui erano stati trattenuti prima presso il centro di soccorso e prima accoglienza di Contrada Imbriacola, poi per breve tempo in un parco sportivo a Lampedusa (in cui avevano poi eluso la sorveglianza della polizia ed erano fuggiti) ed infine a bordo di due navi a Palermo, appositamente e momentaneamente adibite ad accogliere i migranti, sulle quali erano stati imbarcati – in attesa del rimpatrio – dopo essere stati nuovamente fermati dalle forze dell’ordine.
La natura di centro di soccorso e prima accoglienza del luogo in cui sono stati accolti in primis i tre ricorrenti costituisce, secondo la ricostruzione italiana, argomento idoneo a confutare la tesi del trattamento “forzoso” proposta dai migranti. In particolare, l’organizzazione stessa del centro smentirebbe qualunque lesione delle fondamentali libertà dell’individuo, essendo questo dotato – oltre che delle primarie strutture di accoglienza – anche di ulteriori servizi, tra cui un’unità di esperti giuridici per l’assistenza legale.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, invece, la gestione complessiva del centro di Contrada Imbriacola era da considerarsi del tutto inidonea a garantire una permanenza dignitosa: sovraffollamento tale da costringerli a dormire all’aperto, sanitari inagibili, nessun servizio mensa.
Le doglianze sono state ritenute valide, in quanto le condizioni in cui i tre tunisini sono stati trattenuti vengono considerate ampiamente integranti l’ipotesi di trattenimento degradante, soprattutto a fronte del fatto che dalle risultanze probatorie e dalla documentazione prodotta sono emerse numerose violazioni delle più elementari condizioni di igiene e sicurezza, riscontrate ed avvalorate anche dalle testimonianze raccolte e presentate in giudizio da associazioni super partes appositamente intervenute[2].
Nello specifico, tali condizioni hanno secondo la Corte una rilevanza notevole e lesiva dei diritti dei ricorrenti, non essendo sufficiente una situazione di disagio soggettivo perchè possa configurarsi la violazione dell’art. 3. Al riguardo, i giudici sono chiari nel sottolineare come non bastino stati personali di preoccupazione o agitazione per integrare una ipotesi di trattamento lesivo della libertà, occorrendo raggiungere una soglia minima tale da risultare grave la lesione dei diritti dell’individuo. Una carenza informativa circa la situazione di fatto o riguardo le procedure seguite[3] – seppure certamente qualificabile come causa di stress – non permette di poter definire come inumano il trattamento subìto.
Un secondo profilo in punto di diritto inerisce la supposta violazione dell’art. 5 CEDU, secondo il quale: “ Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;
e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione ”.
La Corte si sofferma su diverse questioni inerenti la disposizione in oggetto, arrivando a conclusioni che accolgono le istanze dei ricorrenti.
Si sottolinea anzitutto la natura delle restrizioni fisiche e materiali cui sono stati sottoposti i migranti: sia il trattenimento presso il centro di prima accoglienza in un primo momento, che il successivo spostamento a bordo delle due imbarcazioni predisposte per l’occorrenza poi, sono stati secondo i giudici imposti ai ricorrenti senza una giustificazione idonea a permetterne una qualificazione di legittimità.
La limitazione della libertà personale, diritto inviolabile dell’individuo, non può che verificarsi nei casi disciplinati dall’articolo 5 della Convenzione, la cui elencazione va considerata come “esaustiva”. Per poter rientrare in una delle ipotesi enucleate dalla norma occorre che la misura limitativa della libertà e sicurezza individuale sia non solo giustificata dalle circostanze del caso concreto, ma anche che costituisca extrema ratio rispetto ad eventuali ulteriori misure adottabili in alternativa[4], che possano maggiormente soddisfare le esigenze di tutte le parti coinvolte, autorità nazionali comprese.
Il ragionamento del collegio giudicante è in linea con l’interpretazione ermeneutica unanime per la quale non possa considerarsi l’applicazione della legge come schema automatico ed immediato di causa-effetto, scevro da ogni valutazione della fattispecie concreta[5]. Le singole condizioni dei ricorrenti, la verifica dell’effettivo stato dei luoghi del trattenimento, l’ulteriore traduzione a bordo delle due imbarcazioni a seguito del tentativo di fuga denotano una situazione che, pur non potendosi qualificare come detenzione a pieno titolo, allo stesso tempo non è definibile quale mera traduzione dei migranti da un luogo ad un altro (e ad un altro ancora) per una migliore gestione del flusso migratorio ed un suo conseguente idoneo controllo.
Il trattenimento dei tre uomini, inoltre, contrasterebbe con il principio generale della certezza del diritto, essendo privo di un fondamento di natura legale nell’ordinamento nazionale italiano, ed a questa considerazione si ricollega anche la violazione dell’articolo 5§2 della Convenzione[6], in quanto le autorità italiane, a seguito del trattenimento, non hanno provveduto ad informare in tempi brevi i migranti di quei “motivi giuridici e materiali” alla base della misura irrogata, ossia di quelle ragioni che sono necessarie sia per poter considerare una detenzione giustificata, sia per permettere eventualmente ai detenuti stessi di opporvisi mediante specifica azione legale.
A questo proposito, infatti, un’ulteriore questione era stata sollevata in relazione al disposto dell’art. 5 § 4 CEDU, in base al quale: “ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima”.
La Corte, prescindendo da un esame concreto dei mezzi di tutela giurisdizionale effettivamente esistenti nell’ordinamento nazionale italiano[7], identifica il mancato rispetto del dettato dell’art. 5§4 CEDU nella circostanza che i ricorrenti non hanno ricevuto informazioni adeguate circa le motivazioni a supporto della privazione della loro libertà. Inoltre, rilevano i giudici, i decreti di respingimento – privi peraltro del fondamento giuridico alla base del respingimento stesso – sono stati consegnati poco tempo prima dell’effettivo rimpatrio, con evidente vanificazione di qualunque eventuale ricorso che fosse stato successivamente presentato dai tunisini[8].
E’ stata altresì riconosciuta sussistente la violazione dell’art. 4 Protocollo 4 alla Convenzione, e dell’art. 13 CEDU in combinato disposto con gli artt. 3 e 5 CEDU e art. 4 del Protocollo 4.
In relazione alla violazione dell’art. 4 Protocollo 4, che vieta le espulsioni collettive di stranieri, è ritenuta qualificabile la procedura di allontamento dei tre ricorrenti come espulsione collettiva, perciò contraria al disposto della Convenzione.
La Corte rimarca che per poter escludere che si verifichi una espulsione collettiva non sono sufficienti decreti di respingimento individuali a seguito di idonea procedura di identificazione, occorrendo invece la sussistenza di adeguate garanzie di una effettiva e singolare “presa in carico” della persona interessata. La semplificazione delle procedure burocratiche alla base del respingimento dei tunisini costituisce pertanto indicazione di un incorretto modus operandi adottato dalle autorità italiane.
Per quanto concerne la violazione dell’art. 13 CEDU, invece, la disposizione sancisce che “ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella [..] Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”.
Al riguardo, l’accoglimento delle istanze dei ricorrenti è stato in questo caso dovuto al carente effetto sospensivo del decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera.
Nello stesso decreto infatti veniva specificato che l’impugnazione dello stesso mediante ricorso (entro 60 giorni) al giudice di pace non avrebbe “in nessun caso” sospeso l’efficacia del decreto. Tale previsione risulta contrastare con consolidata giurisprudenza della Corte, laddove si precisa che l’effetto sospensivo dell’esecuzione della misura contestata costituisce condizione di effettività del decreto stesso, la cui mancanza di conseguenza ne inficia l’efficacia in quanto integra una “esigenza” che “non può essere prevista in maniera accessoria”.
In considerazione di quanto esposto la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia al pagamento di una somma di euro 10.000 ad ognuno dei tre ricorrenti per danni morali, nonché di euro 9.344,51 a titolo di spese complessive, riconoscendo la violazione del loro diritto alla libertà e sicurezza a seguito della sottoposizione illegittima ad un trattenimento degradante e inumano, qualificabile come espulsione collettiva non giustificata.
Dott.ssa Chiara Pezza
[1]La stessa Corte, nel corpus della sentenza, parla di “onere sproporzionato per l’isola di Lampedusa”.
[2]Amnesty International, Commissione del Senato nominata per verificare le effettive condizioni dei luoghi in cui i migranti venivano temporaneamente ospitati.
[3]Nello specifico “sono stati informati, in una lingua che comprendevano, dello status che secondo le autorità nazionali era il loro, ossia quello di cittadini tunisini temporaneamente ammessi sul territorio italiano per ragioni di «soccorso pubblico» ai sensi dell’articolo 10 § 2 b) del decreto legislativo n. 286 del 1998”.
[4] Misure che siano dunque state vagliate e considerate “insufficienti per salvaguardare l’interesse personale o pubblico che richiede la detenzione”.
[5] Occorre infatti fare riferimento, secondo la Corte, ad “un insieme di criteri specifici […] come il genere, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della misura considerata”.
[6] “Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico”.
[7] D’altronde, come riportato in sentenza, “non è compito della Corte chiedersi quale potrebbe essere il sistema più appropriato nel campo esaminato”.
[8] Il rispetto di una tempistica celere, ex art. 5§4 CEDU, richiede infatti una “diligenza particolare”.