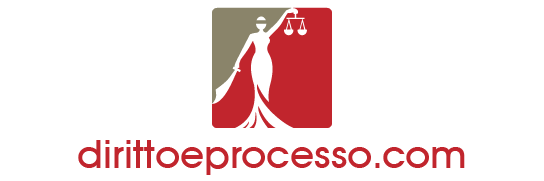MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DEL GIUDICE DI PACE: DUE ISTITUTI DIFFERENTI
di Mario Tocci
avvocato in Cosenza, dottore di ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” nell’Università della Calabria
Con una recente sentenza pubblicata il 23 marzo scorso, il Giudice di Pace del Mandamento di Napoli – nella persona dell’avvocato nolano Felice Alberto D’Onofrio – ha fantasiosamente statuito che nei giudizi instaurati innanzi al Giudice di Pace ed aventi ad oggetto controversie su materie in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità il previo esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 non si debba applicare la disposizione normativa medesima in quanto a ciò osta la sussistenza degli artt. 320 e 322 del Codice di Procedura Civile, a mente dei quali nell’ambito del rito de quo vertitur sarebbero già contemplati istituti di composizione bonaria delle controversie.
In particolare, è disciplinata la conciliazione di soggetti in lite:
- in seno ad un giudizio già pendente, dall’art. 320 del Codice di Procedura Civile;
- in limine di un giudizio non ancora instaurato, dall’art. 322 del Codice di Procedura Civile.
Invero, secondo il magistrato onorario partenopeo, proprio la previsione di simili istituti compositivi in era preesistente a quella della promulgazione del D. Lgs. 28/2010 giustificherebbe l’esclusione dell’applicabilità dell’istituto mediatizio di promanazione comunitaria nei procedimenti testé cennati.
L’assunto è del tutto destituito di fondamento giuridico oltre che logico.
Sul piano dei contenuti, in via preliminare, bisogna infatti osservarsi che l’istituto della mediazione civile e commerciale di cui al D. Lgs. 28/2010 non ha fisionomia analoga a quella amministrabile dal Giudice di Pace.
Divergono infatti gli istituti de quibus per connotazione del soggetto gestore, modalità operative di gestione e struttura instrinseca.
Quanto al soggetto gestore, è da sottolineare che il Giudice di Pace, a differenza del mediatore, è un soggetto nominato in virtù della mera delibazione formale di titoli per esercitare una funzione aggiudicativa del torto e della ragione (perlopiù alla luce della rigida applicazione delle disposizioni normative ordinamentali); come tale, costui non riceve una formazione specifica sulle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie, non avendone bisogno per l’esercizio concreto della propria funzione.
Piuttosto, il mediatore diviene tale dopo essersi sottoposto a un rigido percorso formativo, specificamente calibrato sulle metodologie di alternative dispute resolution, nonché a seguito del superamento di un esame serio e rigoroso.
Pertanto, passando all’analisi della struttura intrinseca dei due istituti in esame, la conciliazione del Giudice di Pace rappresenta praticamente un’anticipazione del giudizio. Giammai essa potrà integrare un’alternativa al, o un’anticamera scongiurativa del, giudizio stesso; ciò in quanto:
- nell’ipotesi ex art. 320 del Codice di Procedura Civile, il giudizio è già pendente;
- nell’ipotesi ex art. 322 del Codice di Procedura Civile, il giudizio è virtualmente iniziato, atteso che in qualsiasi ufficio giudiziario si va con animo belligerante e non certo compositivo.
Le considerazioni da ultimo tratteggiate hanno un riscontro storico incontestabile.
Il modello che informa gli istituti di cui si sta discettando è evidentemente quello teorizzato da Frank Sander, definito “Multi-door Courthouse” e purtroppo di scarsa applicazione pratica: segnatamente, un modello secondo cui i palazzi di giustizia dovessero avere più porte, ossia i sistemi giurisdizionali dovessero prevedere più modalità di risoluzione delle lite e nel novero di queste contemplare procedure compositive extra-processuali.
Orbene, il sistema giurisdizionale – quasi lessicalmente – non può serbare alternative a sé stesso.
Riguardo poi alle modalità operative di gestione, è indubbio che la negoziazione condotta dal Giudice di Pace non potrà che avere tipologia distributiva di torto e ragione, influenzata inevitabilmente dal modus agendi del magistrato onorario, abituato a dirimere contrasti mercé imposizione di un proprio orientamento. Contra, la negoziazione del mediatore è cooperativa, agevola tra le parti la reciproca comprensione degli interessi e dei bisogni e non culmina mai con un’imposizione del terzo mediatore stesso.
Inoltre, la conciliazione del Giudice di Pace è comunque sempre facoltativa.
Se fosse vera la tesi della fungibilità di questa con la procedura mediatizia di cui al D. Lgs. 28/2010, si potrebbe verificare – paradossalmente – che, nelle controversie su materie in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità, il pregiudiziale esperimento del tentativo compositivo mai abbia luogo.
In buona sostanza, la conciliazione del Giudice di Pace è da considerare archiviata definitivamente con la riforma del 2010 che ha rimesso la mediazione al centro di un autonomo sistema separato da quello della giustizia, dotato di propri significati e proprie forme di regolazione.
Dimostrazione ne è che il considerato n. 12 della Direttiva 2008/52/Ce prevede espressamente che la procedura di mediazione non compendia i tentativi dell’organo giurisdizionale o del giudice chiamato a risolvere la controversia nel contesto del procedimento giudiziario concernente tale controversia.
Afferma poi l’avvocato D’Onofrio, nella sentenza mentovata, che il D. Lgs. 28/2010 conterrebbe norme posteriori cronologicamente rispetto a quelle di cui agli artt. 320 e 322, che però costituirebbero norme speciali e dunque non derogabili mercé mera applicazione del criterio cronologico di coordinamento tra fonti del diritto, espresso dal brocardo latino lex generalis posterior non derogat priori speciali.
L’asserzione è errata.
Alla questione di specie deve trovare applicazione il più importante criterio gerarchico di coordinamento tra fonti del diritto, espresso dal brocardo latino lex superior derogat inferiori, in omaggio al quale la norma di rango superiore deroga sempre a quella di rango inferiore.
Le disposizioni del Decreto Legislativo 28/2010 sono state emanate a seguito dell’approvazione della Legge delega 69/2009, ulteriormente recettiva della Direttiva 2008/52/Ce.
Soccorre a riguardo la nota sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale, con la quale la Consulta stessa ha statuito il principio secondo cui le norme destinate a dare attuazione a norme comunitarie sono di rango subordinato alla Costituzione e sovraordinato alla legge ordinaria, trovando la propria ragion d’essere nel disposto del primo comma dell’art. 117 della Carta Costituzionale, che impone a tutte le leggi – statali e regionali – il rispetto dei “vincoli derivanti dagli obblighi internazionali”, vale a dire il rispetto del diritto internazionale pattizio.
Tanto detto, va pure stigmatizzata l’inammissibilità di un’eventuale consultazione referendaria – invocata, tra gli altri, dall’attuale Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli – avente ad oggetto le disposizioni del Decreto Legislativo 28/2010.
Da ritenersi, infatti, è che il D. Lgs. 28/2010 rientri nel novero delle cosiddette “leggi comunitariamente necessarie”.
In merito ai requisiti per l’ammissibilità del referendum abrogativo, la Corte Costituzionale, partendo dal limite degli obblighi internazionali sancito dall’art. 75 della Carta Costituzionale, ha elaborato una giurisprudenza che al referendum medesimo riconduce anche un nuovo limite, quello delle “leggi comunitariamente necessarie”.
Orbene, fin dal 2000, la Consulta non ha ritenuto ammissibile il referendum su quelle leggi che sono indispensabili affinché lo Stato italiano non risulti inadempiente rispetto agli obblighi comunitari, dal momento che l’eliminazione di tali norme è possibile solo con la contemporanea introduzione di disposizioni conformi al diritto dell’UE (sentt. 31, 41 e 45 del 2000).
Espunto dall’ordinamento interno il D. Lgs. 28/2010, si creerebbe un vulnus con riferimento alla conformità comunitaria dell’ordinamento stesso.
E, da ultimo, peraltro, la Corte Costituzionale si è pure preoccupata di non violare la cosiddetta “clausola di stand still”, enucleata dalla Corte di Giustizia, secondo la quale anche in pendenza del termine di recepimento delle direttive gli Stati non devono adottare normative interne in grado di ostacolare o ritardare l’applicazione del diritto comunitario; difatti, con le summenzionate sentenze 41 e 45 del 2000, la Consulta ha ritenuto inammissibili quesiti volti ad eliminare disposizioni vigenti già conformi a direttive comunitarie in via di recepimento, sulla base della tesi secondo cui non può crearsi una disciplina nazionale in conflitto con i principi contenuti nelle direttive da attuare.